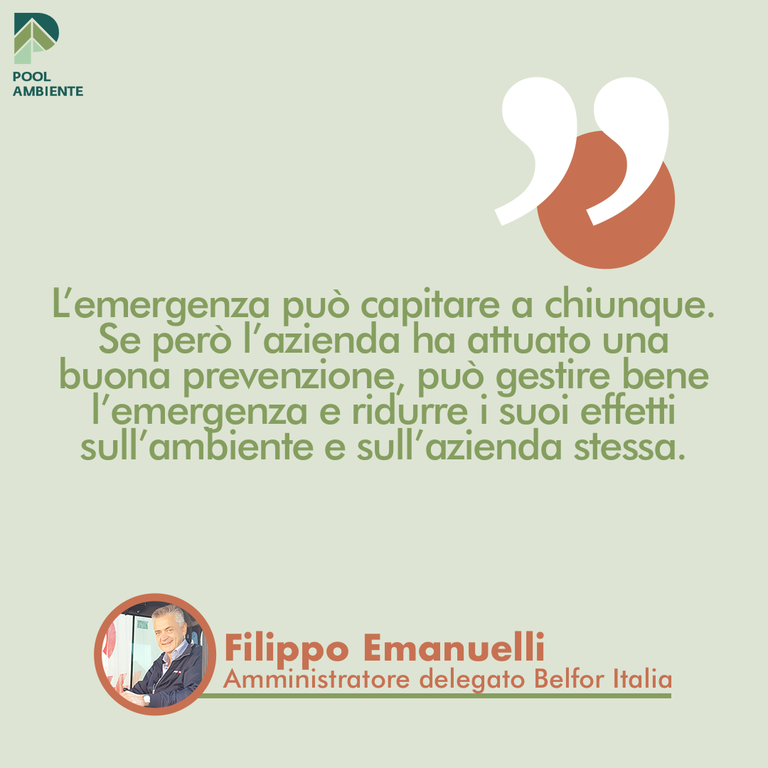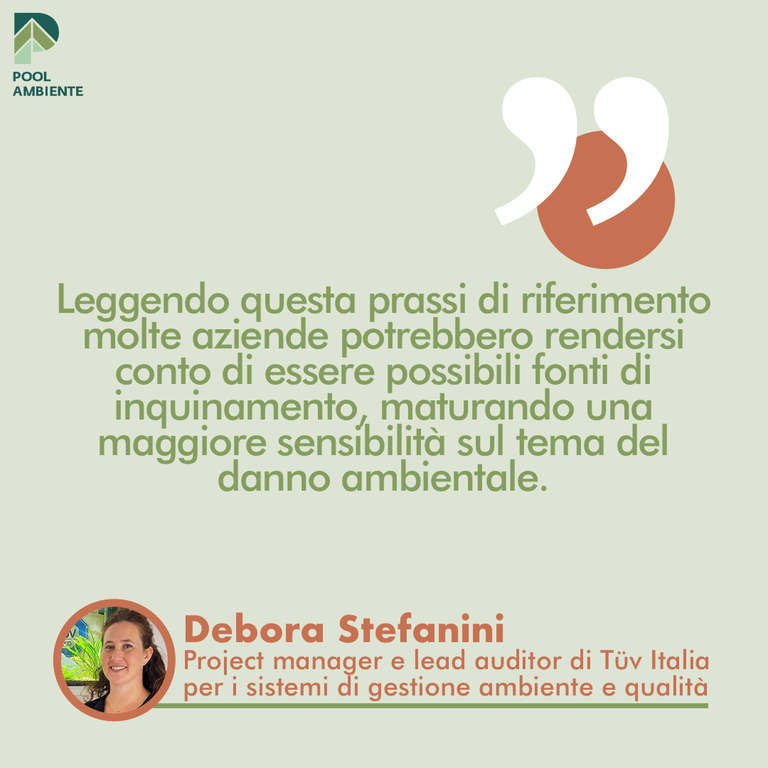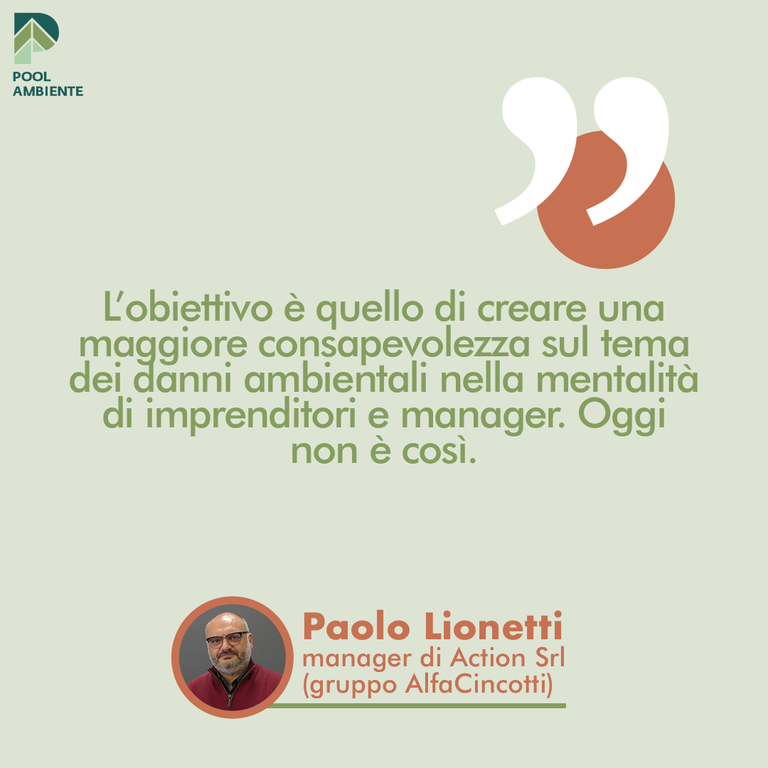L’ambiente va protetto, a cominciare dalla prevenzione
Da Pool Ambiente e Uni nasce la prima prassi di riferimento per le imprese che non si accontentano di riparare i danni ambientali, ma fanno tutto il possibile per evitare che accadano.
Tempo di lettura: 22 min.
In Italia possiamo ritenerci fortunati, perché l’attenzione e la consapevolezza verso l’ambiente crescono a vista d’occhio. Basta aprire un giornale per notare che innumerevoli aziende si stanno impegnando per ridurre le emissioni di CO2, recuperare e riciclare i rifiuti, approvvigionarsi di energia da fonti rinnovabili. Che dire, però, dei danni ambientali? Gli sversamenti di sostanze tossiche, le esplosioni, le contaminazioni ed episodi simili purtroppo sono accaduti in passato e continuano ad accadere, per errore umano, difetti tecnici, carenze in controlli e manutenzioni o motivi esterni. In caso di danno all’ambiente la nostra normativa è tra le più severe del mondo e obbliga i responsabili a riparare quanto si è danneggiato e a riportare le risorse naturali alle condizioni originarie. Peccato, però, che abbia un angolo cieco: quello della prevenzione. Per com’è strutturata, infatti, la legge interviene solo quando ormai il danno è fatto. E anche non volendo intervenire con obblighi sulla prevenzione ma con incentivi, va osservato che manca un sistema premiante per le imprese che, indipendentemente dalle leggi, si attivano per ridurre al minimo la probabilità che questi danni si verifichino. A colmare questo vuoto è arrivata la prassi di riferimento Uni Ambiente protetto, ideata e promossa da Pool Ambiente.
Indice:
- I promotori: Pool Ambiente
- I promotori: Uni, ente italiano di normazione
- Lo strumento: una prassi di riferimento
- L’albero della sostenibilità ambientale
- Le possibili sorgenti di danno ambientale
- L’autovalutazione di vulnerabilità
- Comprendere gli scenari di rischio
- Criteri generali e criteri specifici
- Requisiti precisi e monitorati costantemente
- Manutenzione, non solo riparazione
- Il valore di una copertura assicurativa
- Un aiuto per il risk manager
- Il punto di vista degli intermediari assicurativi
I promotori: Pool Ambiente
La prima vera catastrofe ambientale della storia italiana ha un nome e una data: disastro di Seveso, 10 luglio 1976. Nello stabilimento chimico Icmesa, un sistema di controllo di un reattore andò in avaria e causò la fuoriuscita di un’immensa nube di diossina. Un episodio che aprì gli occhi di tutti su quanto potessero essere disastrose le conseguenze di un incidente industriale.
Tre anni dopo nasceva Pool Ambiente (all’epoca Pool Inquinamento), con lo scopo “di unire le forze delle compagnie di assicurazione e riassicurazione per poter supportare al meglio le aziende nella gestione dei rischi ambientali e degli eventi di danno”, racconta il presidente Tommaso Ceccon. Oggi ne fanno parte 22 compagnie che, dopo migliaia di sinistri gestiti, sanno assistere passo dopo passo chi deve riprendere le attività, eseguire bonifiche e ripristini e risarcire i danni. “Il consorzio, in questi 42 anni di esperienza, ha maturato un know how tecnico che rappresenta un patrimonio unico e straordinario che vogliamo mettere a disposizione degli stakeholder, delle comunità in cui operiamo e, più in generale, del tessuto imprenditoriale del nostro paese”, ricorda Ceccon.
Sulla base di questa esperienza, Pool Ambiente ha individuato un grosso punto debole nel nostro sistema. La sostenibilità ormai è un fattore di sopravvivenza per le imprese, perché è il criterio che guida le scelte di una quota di consumatori sempre più ampia. “La comunicazione ambientale delle aziende è molto concentrata sulla misurazione delle performance: i rifiuti da smaltire, i consumi di acqua ed energia, le emissioni di CO2. Questi sono aspetti importantissimi su cui i quadri di riferimento e le certificazioni esistono e sono molto efficaci”, puntualizza Ceccon.
Sui rischi ambientali, invece, la consapevolezza è molto più flebile. Le piccole e medie imprese, spina dorsale della nostra economia, spesso non sospettano di essere una possibile fonte di danno. Di conseguenza non mettono in campo le opportune misure di prevenzione né si tutelano con una copertura assicurativa adeguata. Se però il danno si verifica, sono sottoposte alla normativa ambientale più puntuale, severa e punitiva al mondo, improntata sul principio del ripristino delle matrici ambientali alle condizioni originarie e della responsabilità oggettiva. Ciò significa che l’azienda deve sempre denunciare l’accaduto, intervenire in tempi stetti e risarcire i danni, anche se non si ravvisa dolo o colpa.
Dal 2015 in poi, per i reati dolosi in materia ambientale l’imprenditore rischia conseguenze concrete: sia sotto il profilo penale, perché sono previsti fino a 15 anni di reclusione, sia sotto il profilo risarcitorio assicurativo, poiché i danni ambientali non sono assicurabili in caso di condotte dolose.
Giovanni Geremia, avvocato presso lo studio legale Geremia&Invernizzi
Ecco perché Pool Ambiente ha riunito una squadra di esperti (AlfaCincotti, Belfor, Igeam, Ramboll Italia, Tüv Italia) e ha istituito un tavolo tecnico in sede Uni. L’obiettivo? Mettere a punto una nuova certificazione capace di coprire queste due aree, la prevenzione e la riparazione del danno ambientale, e incentivare le aziende a investire nella prevenzione come e più di quanto magari facciano sulla sostenibilità. La prevenzione è infatti la vera chiave di volta di un corretto rapporto della nostra società con l’ambiente in cui viviamo.
Gli esperti che hanno partecipato al tavolo tecnico:
- Alfacincotti – Paolo Lionetti e Corrado Viazzi
- Belfor Italia – Filippo Emanuelli e Nicola Veglia
- Igeam – Silvia Monari
- Pool Ambiente – Lisa Casali e Roberto Ferrari – Pool Ambiente
- Ramboll Italia – Emiliano Micalizio e Daniela Nissim
- Tüv Italia – Debora Stefanini, Roberto Muoio e Caterina Prandi
- Uni – Viviana Buscemi






I promotori: Uni, ente italiano di normazione
Per realizzare questo proposito Pool Ambiente ha potuto contare su un braccio destro di tutto rispetto. Stiamo parlando di Uni, che proprio nel 2021 festeggia i suoi cent’anni come ente italiano di normazione. “Facciamo standard tecnici, cioè documenti che definiscono come fare bene le cose in vari ambiti: come si fanno i prodotti, come si erogano i servizi, come si svolgono determinate professioni”, spiega la responsabile Innovazione e sviluppo Elena Mocchio.
Uni non è da solo a redigerli, poiché riunisce una serie di soggetti competenti – associazioni di consumatori, ong, enti pubblici, imprese, università, rappresentanze del mondo industriale – che si confrontano e alla fine raggiungono un consenso. Gli standard tecnici non vanno confusi con le leggi visto che la loro applicazione è volontaria (salvo rare eccezioni). E sono un valido supporto anche per chi desidera incamminarsi verso la sostenibilità. “Sono centinaia le norme che possono essere usate a supporto della sostenibilità nelle sue varie dimensioni. Solo per fare alcuni esempi, ci sono le norme Iso serie 14000 sulla gestione ambientale o la norma Iso 26000 sulla responsabilità sociale d’impresa. A me piace aggiungere anche un altro pilastro, cioè il tema della collaborazione: serve un’interazione stretta tra pubblico e privato per far sì che la sostenibilità sia davvero vincente”, continua Mocchio.
Lo strumento: una prassi di riferimento
Gli standard tecnici Uni si possono suddividere in due grandi famiglie. “Da una parte abbiamo le norme che dicono come fare bene le cose. Dall’altra abbiamo le prassi di riferimento che anticipano quello che, un domani, sarà lo stato dell’arte”, spiega Viviana Buscemi, technical project manager Innovazione e sviluppo Uni. Considerata l’assenza di standard tecnici intersettoriali che regolamentino il campo della prevenzione dei danni all’ambiente e quindi la portata innovativa di una regolamentazione di questo tipo, Pool Ambiente ha quindi scelto la strada della prassi di riferimento, dandole il nome di Ambiente Protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente – Criteri tecnici per un’efficace gestione dei rischi ambientali. Una volta diventata lo stato dell’arte, potrà essere convertita in uno standard tecnico.
“Lo sviluppo di una prassi di riferimento è più veloce perché c’è l’esigenza di essere tempestivi sul mercato. Quando un soggetto esterno (in questo caso Pool Ambiente) fa una proposta, noi creiamo un tavolo tecnico composto da alcuni esperti nominati dal proponente e da altri che fanno parte del Sistema Uni. Dopo averne delimitato lo scopo e il campo di applicazione, verificando che non si sovrapponga ad altre norme già in uso, i membri del tavolo tecnico scrivono il documento. È prevista anche una fase di consultazione pubblica in cui chiunque può leggere la bozza e inviare i propri commenti. Una volta pubblicato, il testo definitivo si può scaricare gratuitamente dal nostro sito”, continua Buscemi.
Le aziende a quel punto sono libere di leggere la prassi e, se la ritengono utile, adottarla. Magari comunicando questo loro impegno ai clienti, ai fornitori e ai partner. “Può essere un ulteriore valore aggiunto chiedere a un ente terzo di verificare la conformità a una norma o a una prassi di riferimento, cioè di assicurarsi che sia stata applicata correttamente”, precisa Ruggero Lensi, direttore generale di Uni. “Alla fine del processo viene rilasciata una certificazione e si può anche usufruire del marchio Uni”.
L’albero della sostenibilità ambientale
L’esito di questo percorso è la prassi di riferimento Ambiente protetto, pubblicata in italiano e in inglese. Alla base c’è una filosofia che può essere descritta con un’immagine, l’albero della sostenibilità ambientale. L’idea è di Lisa Casali, manager di Pool Ambiente e green influencer, che ha coordinato il tavolo tecnico. “Oggi siamo bombardati di messaggi sulla sostenibilità, ne sentiamo parlare continuamente”, spiega. E questo complica le cose: “Per i consumatori è difficile distinguere i prodotti che siano realmente a basso impatto, mentre per le aziende è difficile stabilire un ordine di priorità”.
Negli ultimi anni spesso ci capita di registrare da parte delle aziende dichiarazioni di sostenibilità del tutto o in parte non veritiere. La sfida per noi è quella di capire se gli strumenti giuridici a nostra disposizione ci permettono di poter contestare reati effettivamente già esistenti, oppure se, a valutazione del legislatore, sia opportuno individuare specifiche figure di reato.
Tenente colonnello Massimo Planera, comandante del Nucleo operativo centrale e C.I. del reparto operativo Carabinieri Tutela ambientale e transizione ecologica
Questa metafora ci guida perché ci suggerisce che l’impegno ambientale deve avere solide radici nella prevenzione dei danni: “Prima di pensare alle performance ambientali bisognerebbe investire perché tutte le potenziali sorgenti di danno e i possibili scenari siano individuati e opportunamente gestiti”, puntualizza Casali. Il tronco dell’albero invece è rappresentato dalle risorse e dagli strumenti con cui riparare un danno all’ambiente affinché tutto possa tornare come prima. In caso di contaminazione del territorio, bisognerà bonificare; se il problema sono le emissioni di CO2, bisognerà compensarle. I rami e le foglie, infine, sono costituiti dagli interventi e dalle attività con cui migliorare le proprie performance ambientali, ridurre le emissioni di gas serra, trasformare scarti e sottoprodotti di lavorazione in materie prime con un approccio di economia circolare, migliorare l’efficienza nel consumo di acqua, energia, materie prime.
Le certificazioni ambientali già esistenti – come le norme Iso serie 14000 e la registrazione Emas – si concentrano sui rami e sulle foglie, cioè sulle performance ambientali dell’azienda. La prassi di riferimento Ambiente protetto invece non si occupa dei processi bensì delle sorgenti di rischio (le radici) e della riparazione di eventuali danni (il tronco). “In questo senso, questi sistemi sono complementari tra loro. Anzi, per un’azienda che ha già altre certificazioni è ancora più facile e veloce implementare Ambiente protetto”, conclude Casali.
L’articolo 41 della Costituzione è stato modificato: oggi la tutela dell’ambiente è espressamente un limite alla libertà di iniziativa economica. Un limite non solo negativo, cioè “chi inquina paga”, ma anche in senso positivo, perché l’impresa contribuisce in maniera determinante a prevenire e gestire il rischio ambientale.
Antonio Barone, professore ordinario di Diritto amministrativo presso l’università di Catania
Le possibili sorgenti di danno ambientale
Qualsiasi azienda, dalla piccola falegnameria artigianale alla multinazionale chimica, può seguire la prassi di riferimento Ambiente protetto; non c’è alcuna distinzione di tipologia, dimensioni o attività. Certamente è chiamata a mettersi in gioco, andare alla ricerca dei problemi e fare qualcosa per risolverli, anche sostenendo dei costi o facendosi affiancare da consulenti. Secondo Roberto Ferrari, responsabile sinistri di Pool Ambiente e vice coordinatore del tavolo tecnico, “è soprattutto una questione di volontà”.
Ascolta l’intervista
Tutto comincia dall’autovalutazione, cioè dall’identificazione delle possibili sorgenti di danno ambientale, dei percorsi e dei bersagli, ovvero chi ne subisce l’impatto. “Dal nostro lavoro di analisi dei sinistri e studio degli impianti, ci siamo resi conto di una cosa: capire da dove può scaturire un danno all’ambiente è molto più semplice del previsto”, spiega Roberto Ferrari. “Qualsiasi impianto prevede un ingresso di materia ed energia, una trasformazione e un’uscita di prodotti e scarti. Durante questi passaggi ci sono alcune aree, da noi chiamate sorgenti, che bene o male sono sempre le stesse”.
- Incendio/scoppio/esplosione
- Serbatoi e vasche interrati
- Condotte interrate e fuori terra
- Serbatoi e vasche fuori terra
- Aree di deposito, processo, movimentazione di prodotti o reflui
- Punti di emissione
- Depuratore o disoleatore aziendale
Per cominciare, quindi, l’azienda mette nero su bianco le sorgenti presenti nel suo sito produttivo perché da queste ultime dipendono i requisiti specifici che dovrà rispettare. Anche la collocazione nel territorio ha un peso: per fare un esempio, la rottura di una tubazione che trasporta sostanze pericolose avrà determinate conseguenze in una zona industriale e conseguenze completamente diverse nei pressi di un corso d’acqua.
L’autovalutazione di vulnerabilità
Il processo che abbiamo appena descritto si chiama autovalutazione di vulnerabilità ed è stato messo a punto insieme a Ramboll Italia, società di ingegneria e consulenza focalizzata sulla prevenzione e gestione dei rischi ambientali e sulla salute e sicurezza su lavoro, con una squadra globale di oltre 16mila professionisti, 80 in Italia. “Il rischio zero purtroppo non esiste, quindi è importante essere consapevoli di quanto sia vulnerabile il sito in cui l’attività produttiva è ubicata”, spiega Emiliano Micalizio, Principal & operation manager di Ramboll Italia.
Questa vulnerabilità dipende da fattori locali come la geologia del territorio, la presenza di falde o corsi d’acqua, la natura del sottosuolo. In termini un po’ più tecnici, possiamo dire che il rischio intrinseco dell’attività va ponderato in base a:
- gli elementi che contribuiscono alla migrazione di sostanze inquinanti nell’ambiente (per esempio, quanto è permeabile il terreno?);
- i bersagli che possono essere raggiunti (c’è una falda acquifera? A che distanza e profondità?)
- il valore dei bersagli stessi (c’è un pozzo per l’irrigazione dei campi che attinge dalla falda?).
“Spesso questi aspetti sono considerati appannaggio di geologi e ingegneri. Noi abbiamo fornito alcune linee guida per far capire al manager o all’imprenditore che una valutazione preliminare approfondita e veritiera può essere svolta anche in autonomia, o con il supporto di uno specialista ma senza spendere grosse cifre”, continua Micalizio. Conoscendo questi elementi diventa possibile svolgere la cosiddetta what if analysis, cioè rispondere alla domanda: “Cosa succederebbe se si verificasse un evento dannoso?”. Quindi bisogna valutare le conseguenze e i possibili costi di ripristino dei danni causati da un incidente. Senza limitarsi all’analisi della vulnerabilità dell’ambiente circostante l’insediamento e delle componenti tecniche degli impianti, ma esaminando anche la possibilità di errore umano.
Ascolta l’intervista
“Poiché il fattore umano è quasi sempre presente, la consapevolezza sulla vulnerabilità dovrebbe influenzare le scelte successive, non solo nella gestione dell’emergenza ma anche nella strategia di prevenzione e nella progettazione degli impianti”, conclude Emiliano Micalizio. “Banalmente, se dovessi scegliere se tenere un serbatoio interrato o fuori terra e nel sito in questione ci fosse una falda acquifera superficiale, sceglierei senz’altro la seconda opzione, laddove altri aspetti di sicurezza non richiedessero necessariamente la soluzione interrata. Spesso però le aziende non hanno questa informazione perché credono sia di interesse puramente geologico”.






Comprendere gli scenari di rischio
Per ipotizzare i diversi scenari di rischio è stato prezioso il contributo di Belfor Italia, società operativa che esegue opere di pronto intervento dopo incendi, alluvioni, inquinamento e calamità naturali. A livello globale gestisce circa 250mila sinistri l’anno in 55 paesi superando i 2 miliardi di dollari di fatturato; dal 1989 è presente anche in Italia, con cinque sedi per un totale di 120 collaboratori.
“Una delle difficoltà principali di qualsiasi azienda, piccola, media o grande, è che l’imprenditore è giustamente concentrato sulla propria attività e non si pone la domanda: ‘E se succedesse questo?’”, spiega a LifeGate l’amministratore delegato di Belfor Italia Filippo Emanuelli. Tanto più perché il danno può essere causato dall’azienda stessa, ma anche da elementi esterni imponderabili; pensiamo per esempio al maltempo o a un incidente su una linea ferroviaria o autostradale o a un’altra azienda vicina. Quest’analisi, che si chiama gestione del rischio, è ancora poco diffusa soprattutto tra quelle piccole realtà che temono sia troppo complessa e onerosa. Per prevenire, però, è indispensabile conoscere le caratteristiche tanto della propria sede quanto del territorio. “L’emergenza può capitare a chiunque. Se però l’azienda ha attuato un’eccellente prevenzione, può gestire bene l’emergenza e ridurre i suoi effetti sull’ambiente e sull’azienda stessa”, precisa Emanuelli.
Belfor Italia ha quindi contribuito alla prassi di riferimento Ambiente protetto fornendo una serie di scenari concreti e reali che possono causare inquinamento, da quelli più tipici fino a quelli meno usuali o poco considerati. “La conoscenza degli scenari di emergenza e della propria azienda permette di ridurre i tempi di gestione dell’emergenza stessa, raccogliendo in tempo di pace le informazioni necessarie alla gestione degli eventuali scenari di rischio, nel totale rispetto delle operazioni da eseguire”, conclude Filippo Emanuelli.
Ascolta l’intervista
Un esempio pratico recente è rappresentato dall’alluvione in Emilia-Romagna. “Durante questo evento atmosferico sono arrivate più di 300 chiamate a Belfor. I tecnici, coordinati dalla centrale di Ancona, hanno stilato una lista di priorità di intervento. La priorità viene data a chi non ha l’acqua, poi si interviene per rimuovere i fanghi e fare una prima sanificazione con gli autospurghi, per poi procedere con altri tipi di bonifica. La seconda priorità è identificare quali tipi di produzione ri-avviare, capire quali sono le attività più urgenti: un magazzino di semilavorati oppure la catena del freddo?”, racconta Emanuelli. “Anche quella in Emilia-Romagna, come tutte le alluvioni, ha portato via tutto ciò che ha incontrato per strada, come i rifiuti urbani che poi ritroviamo sulle spiagge. Ma l’acqua svuota anche i depositi sotterranei: uno dei primi interventi, infatti, ha riguardato un deposito di carburanti che rischiava di contaminare le acque di falda”.
Emanuelli ci guida passo per passo in un intervento puntuale quale quello che ha riguardato la stazione di rifornimento: “In questo caso, i serbatoi interessati erano stati danneggiati dall’acqua. L’azienda rispettava un corretto stoccaggio dei fluidi, perché non si trattava di un serbatoio appoggiato sulla terra ma dotato di paratie di cemento, quindi la maggior parte del carburante era rimasta in questa area. Siamo intervenuti per sezionare i circuiti, abbiamo aspirato tutti i liquidi fuoriusciti, poi abbiamo svuotato il serbatoio e, correttamente, l’azienda ha voluto raccogliere tutto il materiale fangoso – una messa in sicurezza d’emergenza – nelle aree limitrofe alla sua struttura per diminuire il rischio di una contaminazione esterna”.
Insomma, ci sono differenti attività di intervento per “salvare” la produzione delle aziende e l’ambiente dalle contaminazioni. Tutte, però, hanno una cosa in comune: diventano possibili ed efficaci se l’azienda è preparata. “La preparazione è ancora un concetto diverso dalla prevenzione: prevenire la contaminazione d’acqua è difficile, se non impossibile. Il rischio zero non esiste. Ma dall’altra parte si possono progettare diversamente le aziende e preparare il proprio personale attraverso dei protocolli. Se le aziende, oltre a una buona progettazione dei propri processi, conoscono quali sono le attività da adottare in fase di emergenza, allora sì che è possibile ridurre di molto il rischio”.
Criteri generali e criteri specifici
Una volta identificate le possibili sorgenti di danno ambientale, la prassi di riferimento elenca una serie di criteri suddivisi in due famiglie:
- I criteri generali si applicano a tutte le aziende, senza distinzioni. Innanzitutto bisogna nominare un responsabile dotato di budget e autonomia decisionale, una squadra dedicata alle emergenze ambientali, un responsabile delle comunicazioni e un team che si occupi di manutenzione. Un altro pilastro è la formazione periodica. I manager sono chiamati a frequentare corsi sulla sicurezza ambientale, mentre gli addetti alla manutenzione andranno ad approfondire gli aspetti più tecnici dei vari scenari di rischio. “Si parte da un minimo di 8 ore annue per il management e 4 ore annue per ciascuna sorgente di rischio”, chiarisce Roberto Ferrari, responsabile sinistri di Pool Ambiente e vice coordinatore del tavolo tecnico. “Insomma, non è un impegno troppo gravoso. A noi piace pensare che sia un arricchimento per le professionalità coinvolte”.
- I criteri specifici invece sono riferiti a ogni singola sorgente. Qualche esempio? Se l’industria possiede un serbatoio interrato, la prassi di riferimento le spiega in che materiale deve essere realizzato, con che frequenza va controllato, di quali dotazioni tecniche deve essere fornito (segnaletica, valvole, misuratori di livello e così via), a quali interventi di manutenzione va sottoposto e ogni quanto tempo, e così via. Così facendo, va a colmare un vuoto. “Non esiste una norma che imponga un’età massima per un tubo o per un serbatoio interrato. Non c’è da stupirsi se dopo cinquanta o sessant’anni si verifica uno sversamento”, ci ricorda Ferrari.
“L’idea è quella di trasformare un costo in un investimento. Spesso e volentieri, un’azienda che deve sostituire un serbatoio vede solo il costo”, conclude Ferrari. La prassi di riferimento invece mette in luce i vantaggi in termini di prevenzione e, perché no, anche di reputazione. “Se la certificazione Ambiente protetto diventerà un criterio di scelta per il consumatore, la sostituzione di quel serbatoio sarà anche un investimento di marketing”.



Requisiti precisi e monitorati costantemente
Per definire i criteri, il tavolo tecnico ha potuto contare sul supporto di Tüv Italia, ente di certificazione, ispezione, testing, collaudi e formazione. Un supporto innanzitutto di metodo, visto che “un requisito deve essere identificato in modo puntuale e univoco, deve avere un suo indicatore di riferimento e dev’essere verificabile nel corso del tempo”, puntualizza Debora Stefanini, project manager e lead auditor per i sistemi di gestione ambiente e qualità. Ma il supporto è stato anche di contenuti, perché sono volutamente stati selezionati dei requisiti generali molto vicini a quelli di altri sistemi di gestione presenti sul mercato. Così facendo, chi ha già adottato altre certificazioni (o intende adottarle in futuro) può ottimizzare le forze perché l’approccio è uniforme. “La prassi di riferimento dice esattamente cosa fare e come gestire ciascuna situazione. Da questo punto di vista è molto innovativa”, continua Stefanini.
Ma come si fa a controllare che l’azienda abbia davvero seguito queste indicazioni e abbia quindi diritto di comunicarlo al pubblico, con tanto di marchio Uni? A questo servono gli audit, anch’essi paragonabili a quelli previsti per altre norme come la Iso 9001 e la Iso 14001. È proprio questo il lavoro di Tüv Italia. Si comincia il primo anno con un audit di certificazione svolto in due fasi, la prima documentale e la seconda con ispezioni in sede. Se la valutazione è positiva viene rilasciata la certificazione che dura tre anni, con verifiche annuali un po’ più “leggere” ma tipicamente condotte in campo. Terminato il triennio, è tempo di rifare un audit più corposo.
Ascolta l’intervista
“Il mantenimento della certificazione è subordinato a questo iter, non c’è nessuno sconto”, sottolinea Caterina Prandi, lead auditor e coordinatrice tecnica degli schemi ambientali per Tüv Italia. “Ogni volta che certifichiamo un’azienda, noi ci prendiamo un rischio d’impresa perché le accostiamo il nostro nome e il nostro marchio. Per questo ci teniamo moltissimo a fare le cose per bene e assicurarci che si sia davvero allineata a certi criteri ambientali e di qualità”.
Ascolta l’intervista
Ogni singolo criterio è declinato su tre livelli: base, medio e avanzato. Ciò significa che un’impresa può cominciare dal livello base per il primo triennio e, una volta messa in moto la macchina, perfezionare i processi e le procedure mirando al livello avanzato. In termini di audit non cambia nulla perché i requisiti da verificare periodicamente sono sempre gli stessi; semplicemente, man mano che si sale di livello, l’azienda dovrà ottemperare a essi in forme, modi e tempi differenti. “Per esempio, all’organizzazione viene richiesto di effettuare simulazioni di emergenze ambientali. Per certificarsi al livello base saranno annuali, per il livello medio semestrali e per il livello avanzato trimestrali”, specifica Debora Stefanini.
Manutenzione, non solo riparazione
Come si decide quando e come eseguire la manutenzione degli impianti? A questo si è dedicato il Gruppo Igeam, che si occupa di consulenza organizzativa nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. “Se sulla sicurezza le aziende ormai sono entrate nell’ordine di idee di dover investire, dato che molte misure sono diventate obbligatorie e le violazioni vengono sanzionate anche penalmente, sui temi ambientali finora sono rimaste un po’ indietro”, fa notare Davide Baroncini, marketing and sales director. “Con il nostro apporto a questa prassi di riferimento abbiamo voluto dare all’imprenditore alcuni elementi certi. Cioè che un impianto ben manutenuto da un lato è più efficiente, produce adeguatamente e senza tempi morti; dall’altro lato, non espone al rischio di guasti, esplosioni e altri incidenti che mettono a rischio sia l’ambiente sia la salute degli operatori”.
Questo, però, a patto che la manutenzione venga eseguita con criterio. “Noi siamo operatori e consulenti nell’ambito dell’asset integrity, il che vuol dire manutenzione preventiva o predittiva degli impianti (dai serbatoi alle macchine rotanti) per assicurarne l’integrità e quindi la sicurezza”, chiarisce Silvia Borghi, Business development manager – engineering di Igeam. Attraverso una serie di studi molto avanzati, si esegue la cosiddetta prioritizzazione degli asset in base al livello di rischio associato a un loro guasto. “Questo consente di ottimizzare i piani di ispezione e fare la manutenzione programmata solo dove serve davvero”, precisa. Sostituire periodicamente tutta la componentistica di un macchinario è una strada molto più costosa e anche controproducente perché una piccola percentuale dei componenti nuovi inevitabilmente porterà con sé difetti di fabbrica o guasti occulti. “C’è un altro concetto che dovrebbe entrare nella mente degli imprenditori: la manutenzione è preventiva. Intervenire a seguito di un guasto significa fare riparazione, non manutenzione”, conclude Borghi.
Ascolta l’intervista





Il valore di una copertura assicurativa
Una volta adottata la prassi di riferimento, l’impresa è sicura al 100 per cento di non provocare alcun danno ambientale? Purtroppo il rischio zero non esiste. Una volta predisposte tutte le misure preventive, quindi, il tassello conclusivo è quello di stipulare una polizza assicurativa per danni ambientali. Ma quante aziende italiane sono a conoscenza di questa preziosa forma di tutela?
Troviamo una risposta nell’ottava edizione dell’Osservatorio sulla diffusione del risk management nelle medie imprese italiane condotto da Cineas – il Consorzio universitario per l’ingegneria nelle assicurazioni fondato dal Politecnico di Milano nel 1987 – in collaborazione con l’ufficio studi Mediobanca.
Quando vengono interpellate sulle minacce percepite, le aziende mettono sul podio gli infortuni sul lavoro, i difetti del prodotto e il cyber risk. Guadagna posizioni rispetto al 2019 il meteo estremo – anche per via della crescente attenzione ai cambiamenti climatici – mentre i danni ambientali compaiono soltanto al quinto posto. Spesso si perde di vista il fatto che questi fenomeni in realtà siano collegati, fa notare Massimo Michaud, presidente del Cineas dal 2018.
Un altro indicatore è la percentuale di imprese coperte da un’assicurazione. In Italia non supera il 5 per cento del totale: in parte perché questa copertura non è obbligatoria, in parte per l’ignorata esistenza di prodotti assicurativi per questo tipo di rischio, in parte per l’errata percezione della portata di alcune coperture assicurative estese all’inquinamento improvviso, e in parte anche per la non completa chiarezza della differenza fra fideiussioni e assicurazioni. Un altro pianeta rispetto a paesi come Spagna e Olanda, dove questa copertura assicurativa è obbligatoria; ma anche rispetto alla Germania dove viene adottata da più di 9 imprese su 10 pur in assenza di imposizioni normative specifiche, proprio per una maggior diffusione della cultura del rischio e della prevenzione, derivante anche da numerosi obblighi normativi sulla prevenzione dei danni all’ambiente.
“Il 15,7 per cento delle imprese con cui noi interloquiamo è convinto del fatto che questi rischi non siano assicurabili, cosa non vera”, spiega Michaud. “Il 26 per cento crede che queste polizze siano troppo costose, il 24 per cento che il rischio di inquinamento sia probabile ma non abbia un impatto così elevato, il 50 per cento che sia remoto; è opinione diffusa che riguardi solo pochi settori che eseguono lavorazioni particolari”. Tutte convinzioni inesatte a cui si può porre rimedio con un lavoro di carattere culturale.
Le spese di salvataggio sono spese di contenimento del danno, in particolare nei sinistri ambientali. Per esempio la dispersione in mare di petrolio in seguito a un incidente: il danno è vero e proprio si produrrà quando e se il petrolio arriverà sulle coste. Il nostro codice considera le spese di salvataggio a carico dell’assicuratore. Le assicurazioni ambientali però sono assicurazioni di responsabilità civile, dove invece è incerto se esista o meno un obbligo di salvataggio. Questo ha dato adito a molta incertezza. La mia proposta è questa: le spese di contenimento del rischio ambientale potrebbero essere oggetto di una polizza ad hoc.
Nicola De Luca, professore ordinario di Diritto commerciale presso l’università Vanvitelli di Napoli
Anche per questo Cineas, insieme a Pool Ambiente, organizza il master in Enviromental risk assessment e management, il primo percorso completo sugli aspetti tecnici, giuridici e assicurativi in materia di gestione dei rischi ambientali. Quando si instaura una cultura della prevenzione, è tutta la collettività a beneficiarne. Perché un danno all’ambiente non è solo un danno all’ambiente, ma è un danno anche alla comunità, all’azienda che è tenuta a sostenere i costi del ripristino, e ai lavoratori che rischiano il posto di lavoro in caso di difficoltà dell’azienda nel far fronte alle conseguenze del danno causato.
Proprio nel contesto italiano, in cui questa sensibilità appare ancora da costruire, un’iniziativa volontaria come la prassi di riferimento calza a pennello. “Il problema degli obblighi è che tendono a diventare deresponsabilizzanti. Standard tecnici di questo genere, invece, consentono di fare una scelta volontaria e dimostrare la propria apertura e disponibilità a essere cittadini responsabili”, conclude Michaud. “Se questi standard sono messi a punto da figure molto esperte in materia, sono anche molto più precisi e tecnici e, di conseguenza, più facili da mettere in pratica”.

Un aiuto per il risk manager
È della stessa opinione Paolo Lionetti, risk manager per Action Srl, società di consulenza che fa capo al gruppo AlfaCincotti. Anch’essa partecipante al tavolo tecnico, AlfaCincotti è la società che, in caso di incidenti, invia sul campo i periti che accertano se i danni siano coperti da assicurazione e in che misura.
A lui possiamo quindi chiedere cosa succede, nel concreto, quando un’azienda incappa in un evento di danno all’ambiente. “Faccio un esempio. Scoppia un incendio che automaticamente genera inquinamento a causa dei fumi e dei materiali che si riversano nel terreno (gasolio, agenti chimici, diserbanti ecc.). Per domare le fiamme i vigili del fuoco usano schiume che, a loro volta, impregnano il terreno e vanno bonificate”, racconta. “Nell’immaginario collettivo, la polizza incendio copre i danni. Questo però è vero soltanto per i danni ai fabbricati e ai macchinari; le spese di bonifica restano in capo all’azienda, e si parla di centinaia di migliaia di euro. A queste spese si aggiunge il risarcimento dei danni a terzi e l’eventuale ripristino di risorse naturali danneggiate dalle fiamme. Quante aziende medio-piccole si possono permettere di spendere cifre del genere in questo momento storico? Dal nostro punto di vista, questo è doloroso. Perché il perito non può fare altro che applicare le regole; e, quando interviene, è già troppo tardi”.
Ascolta l’intervista
Da qui la scelta di contribuire alla prassi di riferimento, con l’auspicio che sia uno strumento di supporto al risk manager, impegnato nell’arduo compito di sensibilizzare il management o il titolare. “Fino a oggi mancava uno strumento di questo tipo, tecnico ma al tempo stesso semplice”, afferma.
Il punto di vista degli intermediari assicurativi
Cosa pensano di quest’iniziativa gli intermediari assicurativi, cioè coloro che di fatto propongono le polizze ai clienti? L’abbiamo chiesto a Marcello Bottazzi, presidente del comitato tecnico-scientifico di Aiba, Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni, che ci invita a riflettere su una cosa: “Il nostro ruolo è quello di fornire all’azienda tutto il supporto necessario nella gestione dei suoi rischi. La catena logica comincia con la conoscenza e poi prosegue con le varie misure di mitigazione e prevenzione, e poi, formulando varie ipotesi, si determina anche l’impatto finanziario dell’ipotetico sinistro; su questa base si procederà al dimensionamento della polizza destinata ad assorbirne l’effetto economico”.
Fornendo linee guida molto mirate proprio in materia di conoscenza, mitigazione e prevenzione, la prassi di riferimento Ambiente protetto sarà sicuramente vista di buon occhio dalle compagnie stesse. “Per fare un paragone, un conto è avere un’auto in regola con la revisione e il tagliando, un conto è avere un’auto con le gomme lisce che non vede un meccanico da anni. Tra un rischio ben gestito e un rischio non gestito, l’assicuratore fa le sue valutazioni”. Con l’auspicio che l’assicurazione per danni ambientali non sia più una scelta illuminata di una nicchia di imprese particolarmente sensibili, ma diventi la regola per il tessuto imprenditoriale italiano.
“Quando accade un danno ambientale, nessuno sa che estensione può avere”, conclude Bottazzi. “Ben venga quindi un contributo tecnico-scientifico per la gestione del rischio, scritto da soggetti che hanno le giuste competenze”.